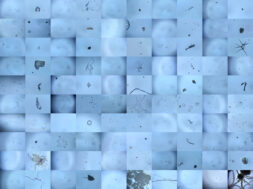Rallentando il tempo: intervista a Alessandro Sciarroni
Due poetiche ben delineate, due percorsi artistici diversi, due ricerche ben distinte, ma che, per alcuni aspetti forse casuali o forse no (le origini natie, la piattaforma Matilde, il progetto europeo Choreoroam…) si incontrano incredibilmente: stiamo parlando di Giulio D’Anna e Alessandro Sciarroni, coreografi – e non solo – appena insigniti del prestigioso Premio Danza & Danza 2012 per la sezione Autori emergenti. Li abbiamo intervistati per andare a fondo nella loro ricerca artistica e saperne di più sui loro progetti.
Nato a San Benedetto del Tronto, Alessandro Sciarroni è un performer, coreografo e regista che ha compiuto studi nell’ambito delle arti visive e in campo teatrale. Dal 2007 ha iniziato il suo percorso come autore vincendo premi e diversi riconoscimenti (leggi qui per approfondire il suo percorso artistico). Ci ha raccontato come nascono le sue creazioni, che cosa gli interessa indagare e dove sta andando…

Alessandro, il tuo ultimo lavoro Folk-s ha vinto il Marte Award ed è stato definito “un capolavoro” dal noto critico Rodolfo Di Giammarco. Ultimamente hai anche ricevuto il Premio Danza & Danza per il tuo percorso artistico e in particolare per “l’indefessa ricerca al confine tra danza, teatro e performing art e la rara consapevolezza intellettuale (…) a cui si aggiunge una maniacale perfezione nei lavori, capaci di restituire suggestioni visive di straordinaria efficacia ed emozioni” come è scritto nella motivazione del Premio. Potresti dirci che cosa ispira e muove la tua ricerca?
Quello che muove la ricerca normalmente è un’intuizione inaspettata: mi capita di trovarmi in un luogo e di assistere a un evento che in alcuni casi mi fa avere la sensazione che il tempo stia rallentando e che mi trovi esattamente in quel luogo e in quel momento. Questo è capitato per esempio rispetto a Folk-s, quando per la prima volta ho visto un’immagine di un danzatore con l’abito tradizionale tirolese-bavarese; è successo l’anno scorso quando mi trovavo ad assistere a uno spettacolo di magia-giocoleria e nel momento in cui ho visto i due giocolieri che lanciavano in aria le clave ho avuto un’intuizione che mi ha fatto capire che quella pratica andava indagata. È qualcosa di assolutamente soggettivo da un lato, ma anche universale. Più si riesce ad andare nello specifico, più si fotografano i dettagli, più si riuscirà a parlare di qualche cosa che riguarda tutti noi.
C’è una volontà di indagine della realtà e società contemporanea nei tuoi lavori? O c’è più un tentativo di esplorare le varie declinazioni di alcuni immaginari collettivi? Come?
In realtà non sono mai esattamente processi consci, sono cose che probabilmente si capiscono dopo che accadono. Se guardo ai miei lavori, nonostante la questione della ricerca sia sempre nata da una specie di bisogno personale di andare a fondo in una certa cosa, mi rendo conto che negli ultimi anni sto cercando di fotografare qualcosa che ha profondamente a che fare con la nostra società; è come se in un certo senso stessi cercando di salvare alcune pratiche che appartengono a dei gruppi molto specifici, all’interno dei quali mi sembra di poter individuare qualcosa che riguarda l’essere umano in generale.
Sono molto contento del fatto che, dopo Folk-s, la ricerca sulle pratiche collettive sia diventata una trilogia. In questi giorni sto iniziando a ricercare sulla pratica della giocoleria, e l’anno prossimo vorrò sicuramente continuare sulla pratica dello sport.

Ci sono dei modelli di riferimento, dei maestri, che hanno influenzato il tuo percorso e che ti hanno aiutato a creare una tua poetica personale?
C’è un’artista in particolare verso la quale continuo a tornare a ogni inizio di lavoro per poi rimettermi sulla mia via, ed è un artista che ha cambiato profondamente la mia maniera di pensare quando avevo 20 anni ed ero un giovane studente di storia dell’arte e di storia della fotografia: si tratta della fotografa americana Diane Arbus (qui per saperne di più, ndr). Riprendere in mano le sue immagini, i suoi diari, è come tornare ogni volta da qualcuno che hai conosciuto benissimo per tanti anni e che oramai non frequenti più. Diane Arbus è stata una straordinaria artista, non una semplice reporter, e il suo lavoro è rimasto da qualche parte impresso nella mia memoria; a volte ho quasi il timore che in un certo senso stia ripercorrendo i suoi passi, ovviamente attraverso il mio linguaggio che è quello della performance, della danza, del teatro e non quello dell’immagine fotografica. L’altro giorno ad esempio ho riletto il progetto che aveva scritto per richiedere una borsa di studio alla Fondazione Guggenheim a New York in cui afferma: «Voglio fotografare la maggior parte delle cerimonie del nostro presente perché mentre viviamo il qui e ora, ne percepiamo solo l’aspetto casuale, sterile e senza forma. Mentre continuiamo a rimpiangere il fatto che il presente non sia come il passato e ci disperiamo rispetto al fatto che il futuro possa continuare ad essere così, queste innumerevoli e inscrutabili tradizioni giacciono in attesa di poter rivelare il loro significato».
Diane Arbus è un’artista verso la quale continuo a tornare e la cui poetica mi ha sicuramente influenzato sia dal punto di vista formale, che sul piano dei contenuti. Rispetto al metodo, all’idea di arte come lavoro, alla questione della disciplina di cui ci si deve dotare per raggiungere un obiettivo, rispetto al fatto che devi essere assolutamente onesto con te stesso quando ti poni davanti al tuo lavoro, l’altro riferimento è e resterà per sempre, il lavoro di compagnia che ho fatto all’interno di Lenz Rifrazioni nella quale ho imparato tutto.
Questo si lega alla domanda successiva: quali esperienze personali si sono rivelate essere dei punti di svolta nel tuo percorso artistico?
Il lavoro con Lenz non è stato solo un punto di svolta, sono stati 9 anni della mia vita di artista; un capitolo molto lungo, un atto unico speso all’interno della verità dell’arte. Ho provato l’amore vero: l’ho provato in maniera profonda in quegli anni e ora posso vivere molto più serenamente, non ne vado più alla ricerca.
Ogni produzione che creo invece rappresenta un punto di svolta: normalmente mi metto in cammino, alla ricerca di cose che non conosco perché probabilmente è lì che mi andrò a riconoscere completamente per quello che sono; per cui ho iniziato il percorso sulla danza folk senza conoscere niente dei balli di tradizione e ora sto facendo lo stesso con la giocoleria. Normalmente fare uno spettacolo sulla cosa che mi interessa, e che mi fa anche paura in un certo senso, è quasi sempre come esorcizzare questa paura.
Sicuramente la produzione di Folk-s è stato un punto di svolta molto radicale perché c’è stato un investimento emotivo molto grande in cui ho dato e ricevuto molto; rappresenta un momento in cui mi sono spinto oltre. Tutto ciò che avverrà dopo non sarà più lo stesso, niente rassomiglierà mai più a quell’esperienza; non penso di poter dire di essere la stessa persona da quando ho prodotto Folk-s. Ed essere qui, poterne parlare ora con serenità è la cosa più bella che poteva accadere.

Residenze, prove aperte, incontri con operatori, dialoghi con altri artisti, feedback esterni dal pubblico. Quanto di queste modalità di lavoro influisce sulle tue creazioni?
Sono esperienze molto diverse. L’incontro con gli artisti è un momento che organizzi, in cui inviti chiaramente un collega a collaborare con te o a vedere un lavoro; è ritrovarsi con qualcuno del tuo clan, quindi è sempre, in un certo senso, un’esperienza che nasce da un bisogno di riconoscersi nel bisogno dell’altro. Fondamentale è stata per la produzione di Joseph la presenza di Antonio Rinaldi durante tutte le prove, ed ora che sto producendo Untitled, ho chiesto al coreografo e musicista spagnolo Pablo Esbert Lilienfeld di seguirmi lungo tutto il percorso.
Gli sharing aperti al pubblico rappresentano invece qualcosa che appena finisco di condividere, penso che dovrà essere l’ultima volta; e invece la volta successiva mi ritrovo in residenza e accetto di aprire dei momenti di prova al pubblico di nuovo! (ride, ndr). Nonostante abbia molta cautela nel mostrare materiali non ancora finiti e cerchi di far capire che non stiamo assistendo ad uno spettacolo ma ad una prova, so benissimo che gli spettatori restituiranno le sensazioni provate e guarderanno la prova esattamente come se fossero di fronte uno spettacolo finito, diranno se si sono annoiati, se si sono divertiti…la cosa più utile la maggior parte delle volte è, mentre fai la prova, sentire che gli spettatori sono lì, percepire la loro energia anche se non dicono niente.
Un paio di settimane fa abbiamo fatto una prova aperta a Santarcangelo dopo solamente 5 giorni che io e 12 giocolieri lavoravamo insieme: ero completamente paralizzato, non riuscivo a parlare al pubblico; è stato un momento imbarazzante tanto ci sentivamo violati rispetto a questo sguardo. Però se ripenso a questa esperienza ho visto il pubblico reagire con applausi a scena aperta alle prove, come se stesse guardando uno spettacolo di giocoleria e non reagendo come se stesse vedendo un evento introdotto in una cornice di danza o teatro contemporanei; per me questa è stata una scoperta incredibile, utilissima. Non direi che gli sharing influenzino, ma che fanno scoprire delle cose molto utili.
Anche con Folk-s sono arrivato a decidere che non sarebbe stata una coreografia completamente strutturata, ma una performance, grazie a uno sharing aperto al pubblico in cui ci siamo resi conto che gli spettatori si stavano annoiando; dopo questa esperienza ho deciso di mettere gli spettatori nella condizione di scegliere se restare o andarsene durante lo spettacolo e mettere il danzatore nella stessa condizione; chiamare in causa il pubblico è una decisione che non avrei mai preso se non avessi fatto questa scoperta.

A quale aspetto del tuo lavoro di artista non riusciresti mai a rinunciare?
Non potrei mai rinunciare al percorso di ricerca, alle prove, alla creazione di uno spazio carismatico intorno ai performer, a entrare in contatto con loro, a condividere un pezzo di strada con loro; credo che questa sia la parte irrinunciabile del mio lavoro, più irrinunciabile delle presentazioni aperte al pubblico, anche se non ci sarebbe motivo di fare quello che faccio se non ci fosse la possibilità di presentare questo davanti al pubblico. In realtà entrambi questi aspetti sono imprescindibili. Penso che l’incontro con le persone in maniera diretta sia la cosa che mi interessa di più.
Cosa speri che si porti con sé uno spettatore dopo aver visto/partecipato/vissuto una tua opera?
Molto sinceramente non penso mai a questo, non penso che uno spettacolo debba far commuovere, ridere, dar fastidio o essere provocatorio. Infatti la prima volta che abbiamo presentato Joseph al Festival di Dro, io rimasi abbastanza stupito, anche piacevolmente, che la gente stesse ridendo di fronte a quello che stavo facendo perché era una cosa che non mi aspettavo.
Essendo io il primo a pormi come spettatore, quando guardo le prove di un mio lavoro, e sapendo cosa provo quando scelgo di mostrare quell’aspetto in un lavoro piuttosto che un altro… ecco, io spero che trovino quello che trovo io.
Quando si riceve un Premio, in questo caso molto prestigioso come Danza & Danza, si dice che sarà da stimolo per far meglio in futuro. Quali sono i tuoi progetti?
Il progetto principale è rappresentato dalla trilogia sulle pratiche performative che finirò entro l’anno prossimo. Ne approfitto per fare un po’ di nomi che vanno ringraziati: i partner marchigiani – Teatro Stabile delle Marche e Amat – sono stati fondamentali per andare avanti in questo percorso poiché riuscire a pensare una trilogia di questo tipo è stato possibile soltanto avendo dei sostenitori veramente interessati ai progetti e alla ricerca. Questa opportunità mi è stata data anche dall’altro grande partner italiano che sostiene il mio lavoro che è il Comune di Bassano del Grappa/Operaestate Festival Veneto, che mi segue e sostiene da anni e grazie al quale sono stato invitato di recente ad entrare nel progetto europeo Modul Dance – che fa capo a 20 case della danza internazionali e grazie al quale siamo entrati in contatto con la Biennale di Lione che co-produce il nuovo lavoro sulla giocoleria assieme al Mercat De les Flors di Barcellona e a Dance Ireland di Dublino. Sempre in Italia, non posso non citare la Centrale Fies di Dro, che da tre anni consecutivi ci aiuta con la produzione, e anche il Festival di Santarcangelo, che è stato particolarmente di supporto quest’anno, ospitando in residenza me e 12 giocolieri.
Intervista a cura di Carlotta Tringali
[Leggi qui l’intervista a Giulio D’Anna]
(136)