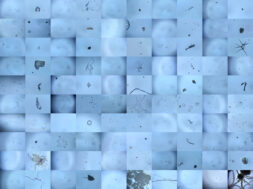Intervista a Claudia Sorace – Muta Imago

Parlami del progetto Displace a cui avete lavorato due anni. Come è nato, come si articola e dove vi ha condotto. Qui a Civitanova avete presentato Displace#1 La rabbia rossa, prima parte di uno spettacolo ben più ampio.
È nato da quando ci siamo chiesti dove siamo, cosa vogliamo e qual è il nostro rapporto con quello che vediamo intorno. La parola displace c’è stata sin da subito, non è arrivata dopo. Siamo partiti da questo termine, dall’idea di riflettere e raccontare che cos’è questa sensazione di inadeguatezza, spiazzamento, spostamento, difficoltà. Basti solo pensare a quando si chiede «Come va?» la risposta è spesso «sempre in salita, però va»: l’idea di essere collocati geograficamente in salita e controvento, su un terreno fragile, su un territorio sconnesso sotto i piedi, in cui ti chiedi continuamente se crollerà o meno, ci ha influenzati molto.
Quindi la prima cosa è stata proprio questo rapporto che c’è con quello che vediamo intorno a noi, così abbiamo deciso di iniziare da Rabbia Rossa – prima tappa del progetto Displace –: una condizione di fatica totale che ci ha fatto ripartire dal nostro corpo e riappropiare di una nostra fisicità, anche di una nostra parte più animalesca, più istintiva. L’idea di essere in un contesto di lotta non è per forza una cosa negativa perché io affronto la lotta, io sto nel terreno sconnesso e in salita, sto qui ora; non posso far finta di stare da un’altra parte, non posso raccontare un’altra storia. Forse è anche un momento bello della vita, non è detto che sia una sconfitta, anzi; in realtà anche l’idea della “rabbia rossa” – che è quella di Jack London – è l’idea di una rabbia che va in fuori, e che, alla fine, costruisce e non distrugge soltanto.
Noi, dopo tutto questo cammino di lavoro, siamo molto più forti: è stato come passare attraverso l’inferno, con la componente della fatica nel fare e disfare (durante le prove abbiamo costruito decine e decine di muri che la mattina innalzavamo e la sera facevamo crollare per verificare e produrre quello che è stato poi il risultato). È un’attività che ha un seme di follia incredibile, ogni tanto nella spossatezza ci siamo sentiti un po’ Fitzcarraldo (il film di Werner Herzog del 1982, ndr), dei sognatori che possono spostare le montagne. Anche nella cupezza e nella desolazione del contesto qui rappresentato (penso anche alla forte presenza del buio) quello che conta è che questi sguardi ci siano e diventino sempre più forti.
Il punto di partenza è stato Rabbia Rossa; poi abbiamo lavorato sul chiederci cosa fossero queste macerie prima di esser macerie e quindi è nata Rovine; come se Rabbia Rossa fosse il nostro rapporto con il presente, la conflittualità da cui poi abbiamo costruito il mondo perduto (Rovine). In Rovine è entrato il canto lirico (il canto-lamento di Didone di Purcell, poi presente anche in Rabbia Rossa, ndr) con una interprete che è anziana, specchio di un mondo delle rovine, dove il muro integro rappresenta un mondo passato che è già inevitabilmente perduto.
Lo spettacolo completo – con anche la terza parte – è molto diverso da Rabbia rossa perché essa si esaurisce tutta su questo forte presente mentre Displace ha un cammino e uno sviluppo narrativo diverso. Lo spettacolo gioca anche sui ribaltamenti e sul ricordo che si ha delle cose durante lo stesso: se prima vedi un muro e poi la sua assenza, quando vivi quell’assenza è diverso se ti ricordi come erano quelle macerie quando erano intatte. Devi stratificare il ricordo dello spettacolo stesso nello spettacolo.
Vi siete ispirati a Le Troiane di Euripide. Ci sono anche altri riferimenti letterari?
In realtà Le Troiane è arrivato un pochino dopo, quando stavamo lavorando a Rabbia Rossa perché a un certo punto ci siamo detti che questa effettivamente era la storia delle Troiane. È sempre molto difficile lavorare su una drammaturgia già scritta: o è un incontro fortunato e ti incontri con un testo nel momento in cui lo stesso ti parla oppure è molto difficile cercare qualcosa da fare, è abbastanza deleterio. È arrivato a un certo punto Le Troiane perché c’erano delle corrispondenze incredibili: le Troiane sono quattro, le performer sono quattro, la condizione drammaturgica che c’era è la stessa (quattro donne sulla spiaggia con un mondo perduto alle spalle, in attesa che arrivino le navi dei greci per portarle via); esemplifica proprio il concetto di displacement.
Guardando Rabbia Rossa pensi alle Troiane e ti ritrovi in quella situazione del passato; ma allo stesso tempo sei consapevole che in qualche modo la stessa condizione appartiene anche al tuo presente: c’è un allontanamento della materia e quindi una comprensione più lucida della situazione in cui viviamo oggi. Pensi che attraverso questo passato si possa capire meglio il presente?
Questo è il modo migliore, secondo me, in cui si possono utilizzare i classici, è questo che fanno e ci raccontano. È chiaro che se non c’è questo passaggio di necessità rispetto al tuo presente, qualsiasi cosa è vuota. Allo stesso tempo le fonti sono fondamentali per dare forza a quello che tu vuoi dire, per fare in modo che allarghino il significato stesso del tuo presente e ti facciano guardare le cose da un punto di vista più ampio.
Le fonti son sempre tante perché Riccardo (Fazi, il drammaturgo di Muta Imago, ndr) porta sempre molti testi durante le prove (è per quello che spesso diciamo che le parole non sono presenti perché il lavoro nasce quasi sempre da fonti letterarie e testuali, non è detto che serva ridire quelle parole).
Il vostro percorso ha sempre riguardato la memoria, da Lev che cerca di ricordare a Madeleine che tenta di dimenticare. In Displace c’è un passaggio ulteriore: c’è un passato, una memoria che è rovina polverosa e l’uomo sembra sospeso su un abisso, in attesa verso un vuoto privo di futuro. Qual è il ruolo della memoria qui?
Io credo che l’idea di lavorare sulla memoria e sul ricordo, quasi sempre, non è uno degli obiettivi iniziali. Credo che si tratti di un qualcosa che ci si crea addosso, dove la memoria è una di quelle ossessioni. L’idea da cui siamo partiti era di provare a riflettere sul presente, però la domanda successiva è stata «che rapporto c’è col passato?». La cosa importante che abbiamo capito, e che rappresenta un passaggio successivo nel nostro lavoro, è che non è detto che le rovine siano una cosa positiva, da salvaguardare a tutti i costi in nome di un senso di appartenenza.
All’inizio l’idea era di prendersi cura delle macerie, ma a un certo punto è diventato chiaro che le macerie sono la zavorra che ci costringe a rimanere dove stiamo e per andare avanti bisogna distruggere ulteriormente quello che ora è pericolante…
Displace ha un elemento di grande ottimismo: la distruzione contiene il germe della rinascita. È un problema quando non vuoi completare la distruzione, quando cerchi di riparar le crepe, perché non puoi andare a costruire un piano più in alto se la struttura non regge. Allora ci siamo detti: il passato è bene che sia distrutto, è bene che venga sbriciolato e reso polvere, perché ci alleggerisce e la leggerezza è un tratto importante nella costruzione del futuro.
In Displace c’è un auspicio che non so dove ci porterà. È più una questione interiore di possibilità ed è paradossale che tutto questo venga da un lavoro che in fondo è sulla distruzione, che in gran parte per noi è stato sulla distruzione.
Penso alla canzone-lamento di Didone che viene cantata in un suo frammento durante Rabbia Rossa: con il famoso «Remember me, but forget my faith» la regina chiedeva di essere ricordata come persona e di dimenticare il suo destino. Qui è come se la donna che canta chiedesse di ricordare l’uomo, l’umanità. Come se ci chiedesse di non ricordare quello che è stato del passato, ma di ricordarci dell’uomo…
Sì, assolutamente. In effetti una delle fonti fondamentali per Rabbia Rossa nello specifico è stata La nube purpurea, romanzo di Shiel del 1901. È un libro strano, apocalittico; non è un capolavoro, però crea un imprinting perché racconta la storia dell’ultimo uomo rimasto sulla terra. Lui faceva parte di una spedizione che andava al Polo Nord – quando ancora al Polo Nord non c’era mai stato nessuno – e nel momento stesso in cui arriva alla meta una nube purpurea devasta l’umanità e quando lui torna, unico superstite di questa spedizione, piano piano comincia a scoprire che sono morti tutti, quindi si affaccia su un mondo morto. Non si capisce bene se è perché lui abbia peccato di hybris varcando i confini… La cosa assolutamente nuova che crea è l’immagine di un mondo distrutto: lui va a Parigi, Roma, Istanbul ed è tutto morto intorno. Inizialmente è molto triste, dopo di che comincia a dar fuoco a tutto quello che rimaneva ancora in piedi che l’uomo aveva costruito e in quella situazione non aveva più senso: comincia a distruggere quello che era già morto, cioè le città che attraversava. Perché in fondo lui è l’unico superstite, lui è la possibilità del nuovo, è il prescelto, è un nuovo Adamo. L’idea che di fronte al mondo distrutto si cominci scientificamente a dar fuoco a quello che è già morto è un ribaltamento mentale, di reagire alla morte con la distruzione. È interessante anche immaginarsi soli al mondo, completamente soli.
Lo spettacolo è molto al buio, però molto importanti sono le luci che tracciano delle strade, sentieri che le attrici seguono faticosamente. Queste strade sembrano portarle da qualche parte, però a un certo punto realizzano che le luci formano un quadrato da cui non c’è via di uscita e da lì subentra la luce rossa, segno che non si ha più alcuna possibilità. Come siete arrivati a questo gioco di luci?
Anche il buio è stato uno dei primi elementi che c’erano, in un luogo costretto c’erano la luce e il corpo prima ancora del gesso. Lavorare a questa difficoltà al grado zero, su un corpo che sta scomodo in un luogo che inizialmente è stato la luce e ora è il buio. Qui in questo luogo definito ed esile quello che non è in luce è dentro il buio.
Il buio è anche il luogo della memoria…
Sì, poi anche come termini di lavoro: l’idea di luce come posto dove il corpo deve stare, ma non è detto che sia il posto felice, della realizzazione perché è talmente esile, è quasi più costrittivo del buio. Abbiamo iniziato a lavorare quasi subito sull’idea di essere intrappolati in questa forma geometrica e sull’idea di considerare la luce come un elemento materiale al pari del gesso, del ferro, degli altri materiali che ci sono. Del resto è tutto trattato così, anche il suono (preso dal vivo ma poi manipolato, trattato). Non c’è nessun elemento che non sia profondamente dentro il racconto e dentro questa situazione qui, e le attrici hanno il difficile obiettivo di fronteggiare tutto questo che gli arriva addosso.
C’è una possibile costruzione di un futuro, oppure l’unico modo per affrontare questo momento è il displacement, ossia lo spostamento verso altri luoghi, se ci colleghiamo al nostro presente, al nostro quotidiano?
Se il percorso è che lo spiazzamento ti porta, attraverso una fatica anche fisica o interiore, a un ricollocamento, a ricostituire una tua unità, così unito e compatto puoi andare ovunque. Forse capire che il mondo è più ampio (e che anche i tuoi limiti si sono allargati) crea un grande scombussolamento all’inizio. La questione principale è dove ti collochi rispetto alla complessità del mondo. Un’entità unita e compatta può muoversi attraverso qualsiasi luogo.
(34)