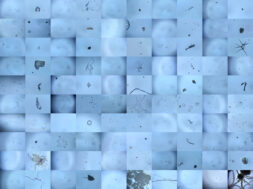pensieri dopo la prova aperta di King Arthur di Motus al Teatro Rossini di Pesaro il 4/10/2014

La materia narrativa proviene dalla sanguinosa guerra tra bretoni e sassoni, rispecchiata nel conflitto amoroso tra i due condottieri Artù (Glen Çaçi) e Oswald che si contendono la non-vedente Emmeline (Silvia Calderoni). Ed è proprio dalla prospettiva di Emmeline che si sviluppa il King Arthur dei Motus.
Nella messa in scena un grande schermo crea uno spazio sovra-scenico. Sullo schermo immagini precedentemente girate si alternano a riprese in diretta fatte da una videocamera sul palco, che passa dalle mani del cameraman Andrea Gallo a quelle degli attori e potenzia l’intensità dell’operazione teatrale. Lo schermo divide il palco in due aree, comunicanti attraverso un varco nel centro e forma uno spazio retro-scenico in cui viene ricreato l’altrove dove la performance è nata, prima di essere allestita in uno spazio più propriamente teatrale.
Nel King Arthur i confini tra le categorie di spazio scenico, retro-scenico e extra-scenico vengono fatte saltare e scontrare per tutta la durata dello spettacolo, fino alla danza finale dove la videocamera, prima sul palco, segue Artù sul retro del teatro per testimoniare il solitario ballo che avviene fuori dalla scena, nel retro, ma è contemporaneamente presente – o meglio rappresentato – sulla scena, attraverso lo schermo e quindi nello spazio sovra-scenico.
I veri protagonisti di questo lavoro grandioso sono lo spazio e l’immagine, insieme alla musica e i corpi sul palco. I corpi dei musicisti dell’Ensemble Sezione Aurea diretta dal violinista Luca Giardini, i corpi dei tre cantanti (due soprani e un controtenore: Laurak Catrani, Yuliya Poleshchu e Carlo Vistoli) e ovviamente i corpi dei performer Silvia Calderoni e Glen Çaçi.
L’immagine è protagonista, quell’immagine il cui accesso è proibito a Emmeline fino ad uno dei punti di svolta dello spettacolo: quando Emmeline prende in mano la videocamera e “un nuovo mondo si precipita nelle sue pupille” e c’è sì Beckett (il Beckett del film con Buster Keaton citato nelle note di lavoro del drammaturgo Luca Scarlini) ma c’è anche il cine-occhio di Vertov nella sua massima potenzialità, che restituisce un senso fisico (la vista) ma anche drammaturgico (di netta centralità) al personaggio di Emmeline.
Immagini, corpi, musiche, spazi, tutto integrato in un kolossal che già nell’originale di Dryden era totalmente sperimentale e che viene in questo caso reso attuale, anzi avveniristico, dall’eccezionale competenza tecnica di cui i Motus si servono per scardinare convenzioni performative e drammaturgiche consolidate. È ancora possibile fare ricerca teatrale – non tutto è stato già detto, non tutto è stato già fatto, non tutto è stato già sperimentato – e i Motus, rifiutando ogni facile scorciatoia post-moderna, indicano con un risultato straordinario le vie che il teatro contemporaneo può ancora percorrere.
Vittorio Lauri
(30)