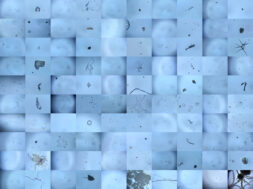La festa dell’insignificanza: l’Ubu Roi di Roberto Latini
Sul palcoscenico un Amleto un po’ folle e schizofrenico, all’ennesimo fallimento di una serie di vani tentativi per pronunciare il suo “to be or not to be”, nel celebre gesto di stringere il teschio in mano, rompe il silenzio con un chiaro “Merdre!”: questa è senz’altro una delle scene più rappresentative e attorno alla quale ruota l’allestimento dell’Ubu Roi diretto da Roberto Latini. Dopo una breve tournée iniziata nel 2012 la produzione di Fortebraccio Teatro è andata in scena al Teatro dell’Aquila di Fermo con uno spettacolo o meglio un “antispettacolo” – come lo definisce lo stesso Latini – che lascia interdetti, senza parole e che stravolge tutti i canonici riferimenti logici degni della drammaturgia teatrale tradizionale.

Sul finire dell’Ottocento, Alfred Jarry con l’Ubu Roi, – dopo aver preso le distanze da quel movimento simbolista del quale aveva inizialmente sposato i principi cardine – apriva le porte al Surrealismo e al filone avanguardista del teatro dell’assurdo. La grande apertura e infinitezza del testo, l’uso assolutamente non convenzionale del linguaggio dei personaggi che, proiettati in un non-luogo e in un non-tempo, reagiscono alle situazioni tanto care al dramma borghese in modo del tutto folle e dissociato – in opposizione al moralismo collodiano e deamicisiano caratteristico della società italiana di quegli stessi anni e all’exemplum dei grandi eroi alle prese con il proprio destino tipico del teatro classico – rendono il testo di Jarry un’opera rivoluzionaria. Il 10 dicembre del 1896, al Theatre de l’Oeuvre di Parigi, la prima dell’Ubu Roi sconvolgeva il pubblico: una platea abituata al rispetto dell’unità di azione, di tempo e di luogo, fedele al principio della verisimiglianza e così obbediente alle intenzioni registiche dichiarate e manifeste della messinscena. L’Ubu realizzato da Latini può, se non sconvolgere, senz’altro spiazzare il pubblico di oggi in modo non così distante dall’Ubu originale.

La messinscena che Latini ci riserva dell’Ubu Roi sfida l’eccesso, porta alle estreme conseguenze la tendenza del non sense originariamente pensata da Jarry, senza mai scadere nel vuoto virtuosismo estetico; i pochi riferimenti spazio-temporali contenuti nel testo svaniscono del tutto nel bianco freddo di una scenografia che aspetta solo la facoltà immaginativa del pubblico per essere riempita. Le figure del Padre Ubu (Savino Paparella) – il re usurpatore assetato di potere – e della cattiva consigliera Madre Ubu (Ciro Masella) – la nuova Lady Macbeth – si abbandonano a insulti e litigi nei quali si mescolano espressioni gergali, arcaicismi, dialetti e giochi di parole. Uno spettacolo che si snoda tra danza, mimo, numeri di circo in cui i personaggi non sono che marionette, esseri caricaturali sospesi in un clima carnevalesco alienante, disorientante e crudele degno di una festa: la festa dell’insignificanza. Emblemi della stupidità del genere umano, le maschere pensate da Latini sono prive di espressività la quale viene colmata dalle loro straordinarie movenze sceniche che fanno da spia alla maestria interpretativa del corpo degli attori. Su di una scena minimale e spaziale vicina agli ambienti visionari di Kubrick, i personaggi dalle mosse meccaniche si guardano e scoppiano in fragorose risate, parlano attraverso delle cornici vuote come a voler dare risalto a delle parole che una logica e un senso non hanno; tra fiori e palloncini fluttuanti c’è chi a cavallo di una scopa è convinto di volare, qualcun altro, in sella a una bicicletta bianca, percorre in senso orario il perimetro del palcoscenico senza sosta.

Il tutto scorre sotto lo sguardo distaccato di un Pinocchio incatenato, uno straordinario Roberto Latini, che dichiaratamente strizza l’occhio alla tradizione di Carmelo Bene. Se veste i panni di un regista o di uno spettatore ideale non è dato sapersi; Pinocchio – da sempre parabola della scissione fra corpo e voce e dell’espropriazione di ogni sentimento – si abbandona più volte alla danza e al gioco acrobatico, col suo fare smanioso e nevrotico, senza poter mai evitare la caduta. Non termina con Carmelo Bene la sfilata degli omaggi ai grandi del teatro, vi è un accenno a Eduardo De Filippo e naturalmente, volendo rispettare il leit motiv dell’originario testo di Jarry, Shakespeare affiora a più riprese dietro alle effusioni di due orsetti, Romeo e Giulietta e lo stesso Pinocchio, nel bel mezzo dello spettacolo, si diverte a recitare la parte di Amleto.
Frequenti sono i ricorsi a “effetti speciali” – i giochi di luce, le pieghe di rossi drappi che disegnano movimenti illusionistici – quasi a voler sfidare le potenzialità e i limiti della scena teatrale, al punto da renderla paragonabile a quella del grande schermo. Il merito della regia di Latini risiede nella fedele reinterpretazione dell’opera originaria che viene sviscerata e sviluppata nei suoi passaggi salienti per essere adattata al tempo teatrale del presente grazie allo spirito di libertà che accompagna ogni scena dell’Ubu Roi. «Io credo nel Teatro. Ovvero, nell’occasione del Teatro» così scrive Roberto Latini nelle note di regia, come a voler invitare il suo spettatore ad abbandonarsi al gioco, e perché no, riuscire per un attimo a sospendere il proprio senso critico frenando ogni necessità di comprensione e di decodificazione per godere di questo appuntamento magico, privilegiato e “patafisico” per dirla alla Jarry, che talvolta il teatro ci riserva.
In quanto parte del progetto Scuola di Platea, il Teatro dell’Aquila di Fermo è stato in gran parte occupato da numerosi giovani studenti degli istituti superiori della città. Scuola di Platea è il progetto promosso da Amat e dal Comune di Fermo allo scopo di introdurre gli studenti alle arti performative, attraverso lezioni propedeutiche alla visione e incontri con le compagnie.


(60)