
Uno spettatore alla volta. Le performance one-to-one fra intimità e personalizzazione di massa
Nell’ultimo decennio le one-to-one performance, o “performance per un solo spettatore”, hanno gradualmente assunto lo statuto di un genere performativo autonomo, particolarmente diffuso all’interno di stagioni e festival, e a cui iniziano a essere dedicate specifiche analisi teoriche e critiche. Il One-on-One Festival organizzato dal Battersea Arts Centre di Londra nel 2010 e il 2011, e i Mono Festival a Lund in Svezia, sono esempi di eventi interamente incentrati su spettacoli in cui a partecipare è un solo membro del pubblico alla volta. Non solo in Nord Europa, ma anche in Italia si è assistito a un incremento di questo tipo di lavori, molto presenti ad esempio negli anni della direzione di Eva Neklyaeva e Lisa Gilardino del Festival di Santarcangelo. Prima ancora, va citata l’esperienza pioneristica della compagnia Teatro del Lemming di Rovigo. Dal 1996, infatti, il Teatro del Lemming ha iniziato con la Tetralogia sul mito e sullo spettatore una ricerca sul senso profondo del mito che si è svolta sperimentando sull’interpellazione dello spettatore: l’Edipo (1997) è una performance immersiva e multisensoriale per un solo spettatore, Amore e Psiche (1999) è fatta per una coppia di spettatori – un uomo e una donna –, Dioniso e Penteo (1998) ne coinvolge nove e Odisseo (2001) trenta per volta.
 Figura 1 – Il Mono Festival di Lund, interamente dedicato a performance one-to-one
Figura 1 – Il Mono Festival di Lund, interamente dedicato a performance one-to-one
Nei mesi del lockdown la “performance per uno” è stata una delle modalità sperimentate più frequentemente dagli artisti, come testimoniato anche da Now/Everywhere dove ne troviamo tre casi: Call My Name di Fabrizio Favale/Le supplici, performance privata dove tramite WhatsApp si assiste a due assoli di danza di 10 minuti; Hamlet Private di Scarlattine Teatro, performance che la compagnia mette in scena dal 2014 che rilegge l’Amleto come scambio confidenziale e che per l’occasione è stata trasferita sulla piattaforma Zoom; Theatre on a line di Cuocolo/Bosetti, dove lo spettatore chiama telefonicamente la performer con cui inizia un dialogo intimo e onirico allo stesso tempo.
Uno dei tratti distintivi delle performance one-to-one, che le rende un oggetto particolarmente indicato per il tipo di riflessione sul rapporto fra teatro e digitale che abbiamo cercato di sviluppare con NEOff, è il loro ambivalente rapporto con la mediazione tecnologica. Esse possono infatti svolgersi in una condizione di massima vicinanza fisica fra corpi, facendo a meno anche della mediazione del dispositivo teatrale. Possono però compiersi anche in modalità dove la relazione fra performer e spettatore è fortemente mediatizzata. Si va da spettacoli in cui l’interazione avviene a distanza – come nei casi visti in questi mesi –, a modalità ibride in cui spazio fisico e digitale si compenetrano – come Wanna Play? (2014) di Dries Verhoeven, dove l’artista olandese contatta tramite la dating app Grindr i partecipanti che vengono poi invitati a svolgere attività quotidiane con lui all’interno di una stanza di vetro trasparente –, fino ad arrivare ad app-performance come Karen dei Blast Theory (2015), software per smartphone che motteggia le applicazioni di life coaching e che produce video motivazionali personalizzati in base ai dati dell’utente.
Le performance one-to-one si dimostrano quindi non soltanto come situazioni performative intime, ma come occasioni dove riflettere sui fattori sociali, culturali e mediali che condizionano la costruzione stessa del senso dell’intimità. Molti degli artisti che lavorano su questa modalità vedono il diffondersi delle one-to-one performance come risposta alla riduzione delle situazioni di intimità in presenza nella contemporaneità. Adrian Howells, fra i nomi più noti del genere, dichiara ad esempio come “there’s a direct correlation between the proliferation of this genre of work and the pace at which our culture becomes more saturated with visual information”. Altri, al contrario, vedono una diretta continuità fra l’intimità tipica della prassi confessionale diffusa sui maggiori social network e le one-to-one performance.
 Figura 2 – Schermata dall’app-performance Karen (2015) della compagnia Blast Theory
Figura 2 – Schermata dall’app-performance Karen (2015) della compagnia Blast Theory
Le radici di questa pratica artistica, tuttavia, precedono la sua recente proliferazione parallela all’ubiquità dei media digitali. Una prima genealogia riguarda quelle performance sviluppate nell’ambito di Fluxus e dell’Happening in cui si ricerca una prossimità fisica e psicologica con membri singoli del pubblico, come Cut Piece (1964) di Yoko Ono o Rhythm O (1974) di Marina Abramović. Rachel Zerihan scorge invece nella performance Five Day Locker Piece di Chris Burden del 1971 uno dei primi casi del genere. Nella performance l’artista statunitense si chiude nell’armadietto di uno spogliatoio per cinque giorni; il focus dell’azione passa però – a sorpresa dell’artista stesso – dalla resistenza del performer alla trasformazione dell’armadietto in una sorta di confessionale davanti al quale le persone raccontano i loro problemi e i propri segreti più intimi. La performance di Burden, in maniera più o meno consapevole, trasforma uno spazio di transito in uno spazio che favorisce la logica relazionale della confidenza. Vi è però un’altra genealogia ben distinta da quella dell’arte d’avanguardia e che riguarda quelle forme di intrattenimento popolare che da più di un secolo fanno parte dell’esperienza delle metropoli: medium, cartomanti, caricaturisti, ma anche le esibizioni erotiche di stripper e dominatrici/tori sadomaso sono, come sostiene il curatore del One-on-one Festival David Jubb, esperienze che hanno sperimentato e diffuso lo spettacolo-per-uno ben prima della sua recente codificazione in genere performativo.
 Figura 3 – Foto dalla documentazione della performance Five Day Locker Piece (1971) di Chris Burden
Figura 3 – Foto dalla documentazione della performance Five Day Locker Piece (1971) di Chris Burden
Questa doppia parentela fra avanguardia e cultura pop rappresenta di fatto una tensione cruciale fra impegno e trivialità che percorre l’ambito della one-to-one performance, fra un tipo di coinvolgimento profondo che mette in discussione le più consolidate aspettative dell’interazione e l’esperienza “sensazionale” a cui si partecipa per l’alto grado di peculiarità. Tale questione trova un ulteriore livello di complessità nel momento in cui consideriamo come la mass customization o “personalizzazione di massa” sia una delle tendenze principali della network society. Dalla produzione industriale alla sanità, dal servizio al cliente all’intrattenimento, la prestazione personalizzata è diventata un’aspettativa generalizzata che ha perso ogni carattere di eccezionalità. Questa però si basa sulla capacità dei sistemi di adattarsi alle varietà individuali mantenendo immutata la propria struttura. Si basa cioè sulla possibilità di elaborare “differenze che non fanno la differenza”. Già nel 1989 Norman Fairclough, uno dei padri della critical discourse analysis, indicava con il termine di “personalizzazione sintetica” una delle strategie più tipiche con cui i discorsi istituzionali e del mercato si rivolgono ai cittadini nel loro complesso simulando però un tipo di contatto uno-ad-uno. Si tratta di un problema centrale anche nel campo artistico e in particolare in quelle definite notoriamente da Nicolas Bourriaud come estetiche relazionali – di cui le performance one-to-one sono considerate da alcuni come una propaggine. Se infatti l’arte relazionale si basa sul presupposto di sperimentare possibilità dell’interazione e dell’aggregazione affinché si possano pensare nuovi modelli dell’azione sociale politica, è anche vero – come sostenuto da Claire Bishop – che lavori di questo tipo possono produrre l’effetto opposto. Essi finiscono infatti con l’elidere – anziché enfatizzare – l’antagonismo insito nelle relazioni sociali. Finiscono cioè per costruire apparati flessibili immuni all’azione individuale, capaci cioè di produrre un differenziale di libertà per lo spettatore su cui si mantiene però il pieno controllo, configurandosi perciò – utilizzando il lessico foucaultiano – come dispositivi governamentali.
 Figura 4 – Copertina dell’edizione italiana di Artificial Hells (2012) di Claire Bishop
Figura 4 – Copertina dell’edizione italiana di Artificial Hells (2012) di Claire Bishop
Oltre alla personalizzazione sintetica della performance, vi è un altro tema su cui si è concentrata l’attenzione critica verso le one-to-one performance e che riguarda l’interrogativo se la predilezione di un rapporto uno-a-uno non possa costituire un fattore di atomizzazione del pubblico. Laddove cioè non vi è quel territorio dell’esperienza condivisa che il pubblico compresente sa di spartire, come fa a costituirsi una base per il discorso critico? Certo questo è un interrogativo su cui vigilare, ma che meriterebbe un tipo di approfondimento empirico e non soltanto speculativo. L’idea cioè che il pubblico esista solo come entità nel qui ed ora della performance rappresenta una prospettiva estremamente miope che non tiene conto di come esso intrecci relazioni prima e dopo l’evento performativo. Ciò è vero a maggior ragione per gli spettacoli one-to-one. Innanzitutto essi tendono a comportare un maggior sforzo dello spettatore nella fase di preparazione, laddove questo si trova a dover entrare in uno spazio relazionale in cui le regole dell’interazione non sono immediatamente conosciute, a differenza di quelle convenzionalmente definite del canonico spazio teatrale. Dall’acquisto del biglietto all’ingresso nel luogo della performance il pubblico affronta un complesso di scelte non automatiche che possono richiedere la negoziazione e il confronto con gli altri partecipanti. Essere dinnanzi al performer, senza la mediazione del pubblico in sala, implica un più alto grado di responsabilità dello spettatore sullo svolgersi dell’evento performativo. Assumere o rifiutare questa responsabilità richiede che si problematizzino le regole di ingaggio, rendendo quindi più espliciti i presupposti del dispositivo. Vi è poi la fase del confronto successivo con gli altri partecipanti, che trova un ulteriore stimolo proprio dalla necessità di comprendere il grado di individualizzazione dell’esperienza appena svolta.
Stabilire a priori che vi sia un’atomizzazione dell’esperienza spettatoriale per mezzo delle performance one-to-one non è quindi molto differente dal concludere che vi sia un effetto di livellamento ogni qual volta ci si rivolge ad un pubblico in maniera indifferenziata – conclusione che gli studi sui media hanno messo in discussione da più di mezzo secolo. Il momento individuale e quello collettivo non vanno cioè visti come opposti, ma come due fasi essenziali dello stesso processo critico. Se il prevalere di una pura individualizzazione mina la costituzione di un territorio comune di riferimento, l’essere perennemente soggetto collettivo impedisce la sperimentazione in prima persona del proprio grado di interiorizzazione/resistenza verso i dispositivi e le aspettative che regolano la vita sociale.
Stefano Brilli e Francesca Giuliani – Redazione NEOff
(334)




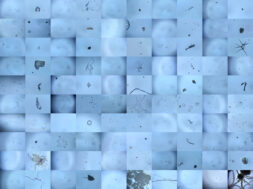






 Figura 1 – Il Mono Festival di Lund, interamente dedicato a performance one-to-one
Figura 1 – Il Mono Festival di Lund, interamente dedicato a performance one-to-one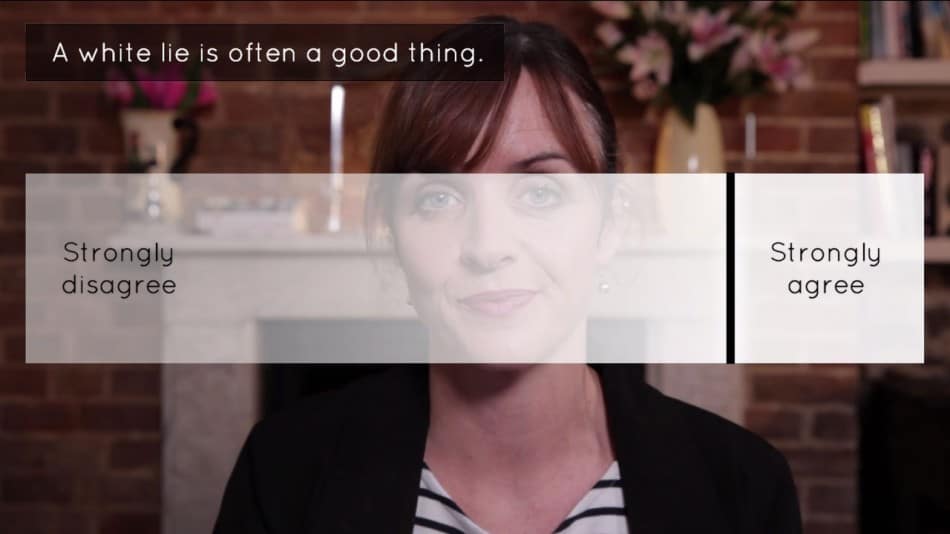 Figura 2 – Schermata dall’app-performance Karen (2015) della compagnia Blast Theory
Figura 2 – Schermata dall’app-performance Karen (2015) della compagnia Blast Theory Figura 3 – Foto dalla documentazione della performance Five Day Locker Piece (1971) di Chris Burden
Figura 3 – Foto dalla documentazione della performance Five Day Locker Piece (1971) di Chris Burden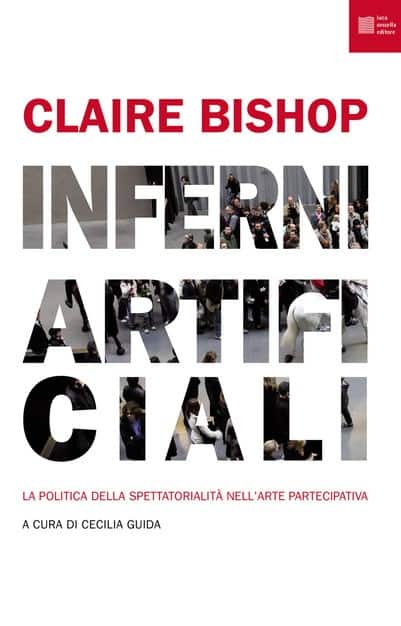 Figura 4 – Copertina dell’edizione italiana di Artificial Hells (2012) di Claire Bishop
Figura 4 – Copertina dell’edizione italiana di Artificial Hells (2012) di Claire Bishop