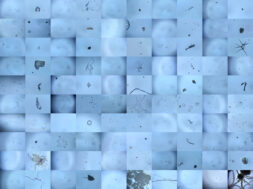Michele Di Stefano racconta “Occhio di bue”

Per un paio di settimane il Teatro Annibal Caro di Civitanova Marche (grazie a Civitanova Casa della Danza, progetto di residenza di AMAT e Teatri di Civitanova) ha ospitato così la residenza del coreografo e dei 7 ragazzi under 13 di Civitanova e comuni limitrofi che hanno preso parte al progetto, ossia Serena Boccaccini, Nicole Cafarella, Riccardo Marcatili e Alice Saccuti di Civitanova Marche, Daria Del Moro e Elisabetta Poeta di Sant’Elpidio a Mare e Sofia La Pietra di Monte Urano.
In occasione della prova generale al Teatro Annibal Caro, prima della partenza e il debutto veneziano, abbiamo incontrato Michele Di Stefano per farci raccontare la sua opera.
Vorrei iniziare la nostra chiacchierata proprio partendo dalla scelta del titolo di questo lavoro: Occhio di bue. Come ci sei arrivato?
Virgilio Sieni ha iniziato a chiedermi delle commissioni particolari e mi è sembrato di dar vita a una sorta di collezione di lavori che potevo mettere insieme perché accumunati dall’essere esperienze di processo con persone che non sono una compagnia, ma si trovano insieme per un’idea molto precisa: a Firenze per esempio, in occasione del progetto Family, ho realizzato lo spettacolo Testa di moro con quattro membri di una stessa famiglia; attualmente, nell’ambito di Vita Nova, sto lavorando con degli adolescenti. Per questa collezione mi sono venuti in mente dei titoli inadatti al teatro ma che fanno riferimento alla pasticceria. In realtà sono espressioni che contengono anche molti altri significati: Testa di moro è un colore, è l’oggetto controverso e coloniale del moretto che sostiene il lampadario delle case borghesi; Occhio di Bue oltre al dolcetto e al faro, è soprattutto la placidità e la serenità di uno sguardo che trova nel ritmo una strana calma.

Volevo creare una grossa frenesia dinamica di movimento e lasciare che si intravedesse il fatto che il danzatore è il responsabile creativo di quello che si produce in scena e che, a sua volta, ciò che si produce in scena dipende da quello che vede davanti a sé. Il metodo di cui mi sono servito consiste in una serie di attività dinamiche molto precise nel corpo: anche se gli adolescenti in scena sembrano improvvisare, stanno elaborando un sistema per il quale hanno a disposizione determinati segni con determinate persone, mentre con altre persone e in diverse situazioni hanno altri parametri; per cui continuamente, mentre danzano, stanno scegliendo, in una specie di frenetica libertà. Lo sguardo, mentre osserva placido, in realtà sceglie: è questo che ho sempre cercato nel danzatore, ossia vedere quel momento di esitazione e di pensiero, quell’autorevolezza creativa della decisione. Mi interessava far capire a queste persone che lo spettacolo sono loro, è il corpo in trasformazione.
Ciò che ho creato per Occhio di bue ha dei grossi margini di rischio ma anche di inventività: se da un lato è sempre garantito un certo risultato perché la combinazione caotica produce una strana bellezza, dall’altro è molto importante trovare l’equilibrio giusto e per farlo l’unica possibilità è affidarsi completamente agli altri. Questo è ciò che ho voluto portare ai ragazzi e che ho detto loro sin dall’inizio: non ci sono assoli, è una danza di gruppo; se lei non danza tu non puoi danzare e tu danzi per permettere a lei di danzare. Dietro a questo discorso c’è poi tutto il mondo di Agamben e della filosofia dell’“essere adiacenti”, dell’essere a proprio agio, della natura della parola “adiacere” che significa “stare accanto”: io danzo per creare lo spazio che permette a un’altra persona di danzare e viceversa.

Ciò che sulla carta poteva sembrare astratto i ragazzi l’hanno ben assorbito: per esempio quando sono insicuri ritornano immediatamente nella modalità “esecuzione”; è bello vedere come di giorno in giorno il margine di rischio aumenta sempre più e vedo che qualcosa in loro sta passando come informazione. Perciò ho creato tre situazioni che hanno anche delle possibilità di diversione, di scarto, di collasso interno – io “flirto” sempre col collasso, ormai è chiaro – e mi è sembrato che loro mi offrissero questa occasione perché hanno un’energia, una freschezza e una qualità di ricezione dell’informazione che appunto dipende dalla loro giovane età. È stato veramente un lavoro di scambio: ho selezionato le persone che mi sembravano potessero aderire al meglio a ciò che chiedevo e così è stato.
Altro elemento che ha influenzato la messinscena è stato l’enorme telo che ho iniziato a portare con me facendo Family a Firenze (e senza sapere bene che farci inizialmente): ho scoperto quanto nascondere sia in realtà rivelatore. Danzando sotto il telo i ragazzi hanno avuto una maggiore difficoltà, ma hanno anche capito che ogni gesto è prezioso perché ogni gesto “improprio” lì sotto diventa gigante…
…e ogni gesto che un danzatore compie sotto il telo condiziona concretamente i gesti e i movimenti delle altre persone (perché il telo si sposta e si modella a seconda del gesto eseguito): è un esercizio pratico che forse aiuta maggiormente i ragazzi nella comprensione del concetto astratto…
È una trasmissione di spazio reale: è come se l’atmosfera diventasse a tal punto densa e pellicolare, come se ci fosse una membrana che provoca questo tipo di informazione. Ho scoperto quindi una palestra eccezionale di lavoro: l’impianto di Family e di Occhio di bue è più o meno lo stesso. Credo sia interessante costruire una cronologia su questi lavori che hanno una sola replica e non perdere così l’esperienza della ricerca. Torna quindi la collezione di cui parlavo prima: sono occasioni in cui posso unire con un tratto dei momenti di ricerca che sono particolarmente utili per me e che non escludo di utilizzare anche per il mio lavoro. Mi affeziono a degli strumenti: una volta era la quinta mobile e adesso è il telo, in ogni caso tutte cose che riguardano il nascondere.
Altro elemento presente in Occhio di bue, che ha a che fare con il nascondere, è la tenda, oggetto in puro stile Mk e che hai già utilizzato in altri lavori. Anche i movimenti e la gestualità dei ragazzi fanno riconoscere immediatamente la tua firma: come hai trasmesso questa grammatica ben precisa del corpo ai ragazzi?
In due modi: uno molto diretto, cioè chiedendo espressamente delle qualità dinamiche e usando un vocabolario impossibile che loro hanno percepito per intensità. È come se avessero intuito una profondità: i ragazzi hanno capito che stavo cercando qualcosa dentro di loro e quindi si sono rivelati, hanno messo a disposizione un corpo.
Inoltre ho elaborato degli strumenti che sono delle grammatiche fittizie per le quali si finge di dire qualcosa per dire altro: li tengo occupati su qualcosa mentre in realtà stanno producendo ‘altro’ e si accorgono successivamente che l’‘altro’ l’avevano già fatto.
Cosa ti porti via da questa esperienza?
Mi porto una condizione di lavoro ottimale, una disponibilità reciproca, la qualità di tempo passato insieme, sostenuto e supportato perché non lo do mai per scontato; un margine di rischio per cui non si procede per mestiere: ci troviamo di fronte a una realtà che ha una sua autonomia, quindi mi porto via il fatto di continuare a lavorare senza sapere bene dove vado. Aggiungo poi che la condizione del rischio è quella che preferisco: se avessi avuto già tutto chiaro dall’inizio, e avessi dovuto soltanto metterlo in scena, non avrei mai fatto questo lavoro. Faccio questo lavoro per vedere che cosa succede realmente: anche quando i ragazzi sono in scena li metto sempre in una condizione di rischio sul risultato. Il fatto di essermi trovato così bene mi dà energia.
Intervista a cura di Carlotta Tringali
– Guarda anche la video intervista a Michele Di Stefano
(155)